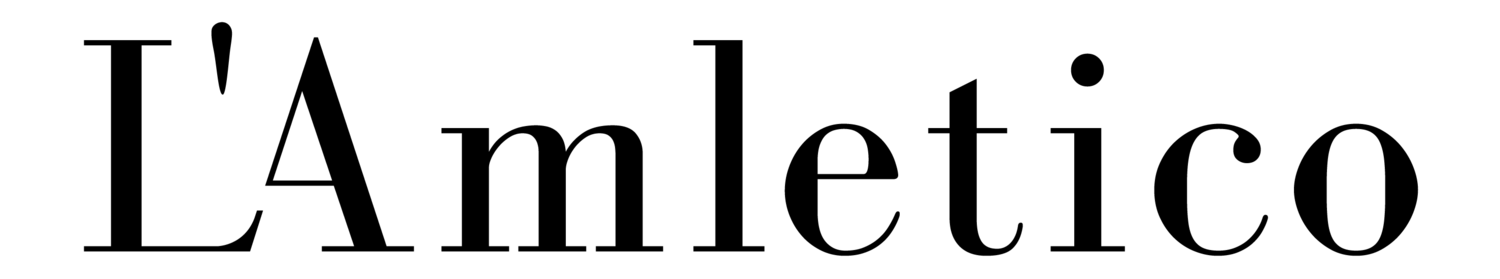Vladimir Nabokov, “Mašen’ka”
«E quando andò a letto ascoltando i treni attraversare quella casa triste dove vivevano sette smarrite ombre russe, la vita nella sua interezza gli apparve come una ripresa cinematografica in cui alcune comparse distratte ignorano tutto del film al quale partecipano.»
Non bisogna addentrarsi molto nella lettura del bel libro, esordio giovanile del 1926 di Nabokov, ma pubblicato da Adelphi solo nel 2022, per incontrare la frase soprascritta e ritrovarsi, così, a tu per tu con l’esplicita sintesi del breve romanzo.
“Mašen’ka” è un libro d’ombre, dolci del passato, popolato da fantasmi.
Il protagonista, il giovane Ganin, vive nella Berlino della repubblica di Weimar, alloggia presso una pension squallida, proprietà di un’anziana vedova russa, assieme ad altri esuli come lui, lontani da quella grande madre Russia, patria rimpianta, guardata volgendo lo sguardo indietro, ad Est e al passato. La vita di tutti i giorni, soprattutto per Ganin, è un susseguirsi di eventi privi di particolare importanza, di ripetizioni, di lavori, lavoretti, di relazioni, storielle, nell’atmosfera fumosa, dai contorni poco definiti, di una casa triste affacciata sui binari del treno.
I personaggi, che come lui vivono nella pension di Frau Dorn, esistono in funzione di un’attesa, sono comparse evanescenti, fantasmi di vite passate che sembrano aver lasciato il proprio corpo nella patria lontana e che, forse chissà, a causa di una qualche ingenua distrazione, non sono trapassati ma sono rimasti fluttuanti in un limbo temporaneo ad infestare una dimora cadente, anch’essa fatta d’ombra.
Ganin, perciò, si sente chiuso all’interno di una realtà sospesa, una realtà irreale, dove i suoi gesti sono gesti vuoti. In una scena frutto del più grande e precoce talento letterario di Nabokov, Ganin, che è andato a vedere un film al cinema, improvvisamente riconosce se stesso fra le comparse, inizia a ricordare i particolari del momento in cui ha girato quelle scene, si rende conto di non aver avuto idea, fino a quell’istante, di cosa stesse facendo, del significato dei gesti che gli indicavano di compiere, del loro significato all’interno del film, e guardando se stesso, fantasma che guarda un fantasma, si rende conto dell’illusorietà della sua esistenza.
Ecco che quindi, nel momento esatto in cui una coincidenza fortuita gli fa tornare in mente Mašen’ka, il suo amore giovanile, lo sguardo ed ogni pensiero di Ganin si volgono istantaneamente al passato, e la sua frustrazione del presente fa sbocciare i dolci fiori dei ricordi, indissolubilmente legati alla Russia, alla patria bella e perduta, all’estate di vacanza dalla scuola, alla campagna profumata e fresca come Mašen’ka, alla salute dopo una malattia: tutto rinasce nella mente di Ganin come una primavera: «l’immagine in boccio raccoglieva e assorbiva tutto il fascino solare della camera senza il quale, ovviamente, non sarebbe mai fiorita.»
Il processo proustiano attraverso il quale Ganin diventa «un dio che ricreava un mondo ormai morto» - e mi si perdoni se nella mia testa tutto ciò che in qualche modo si ricollega al grande scrittore francese sia lodevole - rende necessaria un’aggiunta a quella sintesi del romanzo fatta in apertura: bisogna aggiungere la «realtà imperitura» del ricordo, la sua presenza fisica, l’unica dimostrabile e veritiera, l’unica che abbia corpo e significato.
Poco importa che, esattamente come nel bellissimo “Ferito a morte” di La Capria, il passato sia suscettibile di essere rimodellato e di apparire migliore di quanto non sia stato, poiché quel che conta non è la pedissequa riproposizione degli eventi, bensì il loro valore in quanto ricordi, la loro esistenza consolatoria nella mente di chi li rivive.
“Mašen’ka” si trasforma in un racconto all’imperfetto, il vago passato dischiude le sue dolcezze alla mente che rifiuta il grigiore del presente e vi si rifugia precipitando nell’oblio: Ganin torna con la mente in Russia, torna con Mašen’ka, ricerca e ritrova i fili spezzati di una storia interrotta d’amore, cullando l’illusione segreta di redimere quella vita da esule con l’idillio in compagnia di Mašen’ka, riannodando la trama trascorsa con quella presente.
Ahimè, le lusinghe del passato sono molto fragili. Le altre ombre russe, ostacoli costanti ai ricordi di Ganin, forse non partecipano della sua stessa visione rosea; a loro il passato può apparire piuttosto come un mostro spaventoso, e subiscono ben più crudelmente la durezza del presente. Le ombre russe forse sono tali solo per Ganin, e cambiano grandemente - è nella loro natura - in base alla luce che le genera. Una simile e inaspettata variazione di luce spezza l’incantesimo nostalgico di cui Ganin è caduto vittima, distruggendo sia il mondo tremulo e fluttuante del presente, sia la fantasia variopinta dei ricordi, che si rivelano banalmente per quello che sono in realtà: «il lontano passato.»
Quei treni il cui fumo ha fino a quel momento offuscato il mondo reale, che potrebbero ricucire i lembi di promesse lontane e speranze future, che fanno da basso continuo al romanzo, chissà che non possano diventare anche la sintesi fra questi due mondi inconciliabili, Berlino e Mašen’ka, traghettando Ganin in una terra ed un’epoca nuove, dove finalmente i ricordi possano assumere l’inconsistenza fluttuante che è loro propria e i gesti del presente possano avere senso e consistenza.