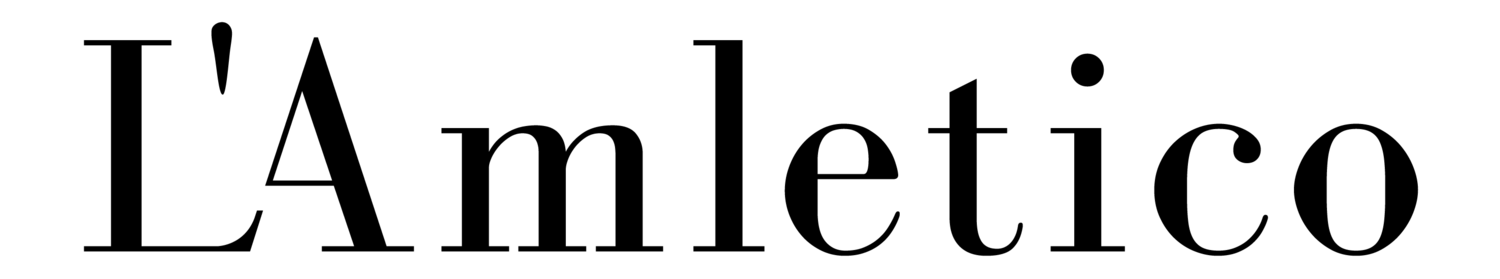TikTok: la Wunderkammer delle disgrazie
Da quando i social network hanno iniziato a sembrare antiquati e tecnologici in modo distopico e anacronistico? Da quando si è passati dal monopolio delle classiche foto da boomer – dai profili normopatici, eppure rassicuranti – all’esposizione più smodata di ciò che prima era censurato? Il fenomeno degli influencer di malattie, di personaggi che costruiscono una carriera su un’esperienza traumatica, o costruiscono una narrazione quando ancora non padroneggiano il linguaggio (nel caso dei baby influencer) è qui da parecchio tempo. Eppure qualcosa scricchiola, e la storia, col suo consueto senso dell’umorismo, sembra rivelare un rigurgito passato mal digerito, che ci riporta direttamente dai nostri schermi ai cabinet de curiosité dove si accumulavano stramberie di ogni tipo. Possesso, brama, fascinazione… cosa manca a tutto questo bailamme di luccicanti reperti? l’empatia, proprio una delle parole più amate e abusate dei nostri tempi, sempre così fuori luogo eppure sempre così necessaria.
Una collezione da esibire: lacrime, malattie, abusi…
1, 2, 3… no, non si cerca più il momento giusto. La diretta inizia all’improvviso, un gigantesco volto deformato da una prossimità che non rivela nessuna familiarità. Il volto estraneo, tuttavia, sembra conoscerci, e si rivolge a noi con un massimo grado di confidenza. Ci riversa le sue sventure, e noi dovremmo forse sentirci onorati di essere messi a parte di cose così delicate, oppure dovremmo provare stima per il coraggio che questa persona dimostra nel mostrarsi così. Sono già tante emozioni e pensieri, eppure c’è dell’altro, c’è molto altro che sfugge e che, oggi, risulta più che mai perturbante.
Il termine tedesco, Unheimlich, sta a indicare un senso di straniante familiarità, un qualcosa che su queste piattaforme viene invertito. Infatti, noi non conosciamo X, l’infuencer di turno che tratta questi temi, ma forse possiamo conoscere il malessere che nel suo canale social esibisce, perché ci siamo passati noi in prima persona oppure conosciamo qualcuno, un amico, un familiare che ci è passato. Bulimia, anoressia, depressione, cancro, leucemia, e chi ne ha più ne metta. Eppure – a pensarci bene – ogni malattia è a sé: chiunque ne fa esperienza ha un suo modo peculiare di viverla, a prescindere da come viene descritta, raccontata, o peggio ancora, divulgata. Ma si cerca l’omologazione anche nei disturbi, anche lì l’individualità è la nemica suprema, perché all’apoteosi dell’individualismo narcisistico social ci sta anche la sconfessione di ogni sorta di genuina personalità. Il carattere, insomma. Troppo difficile sopravvivere come sé stessi in un continuo gioco di specchi, di selfie e immagine raddoppiate, ostentate e poi cancellate, di filtri e ritocchi aggiunti e poi di culto idolatrico per il nude, per il nature.
Camillo Langone, in una delle sue provocazioni, crea un parallelo fra il fenomeno social delle malattie “virali”, ma potremmo dire anche “virtuali”, e certa arte contemporanea che esibisce la deformazione, del reale e del corpo. Il recupero di una forma tradizionale, come quello della vanitas, fa riflettere sul fatto che oggi, in effetti, se gli “influencer delle malattie” sembrano porsi sotto l’ala progressista della “sensibilizzazione” rispetto certe tematiche, per aumentare la consapevolezza comune, i fenomeni di speculazione, dove si vede il gusto per il grottesco e la pronografia del dolore, rimandano a scenari passatisti dove la mercificazione fa corpo con l’esotizzazione, riportando in vita i freaks, i nani di corte, i giullari e gli altri personaggi del folklore elitario.
Il collezionista del Seicento che amava i naturalia amava al tempo stesso dei proto-robot, sorta di bambole a orologeria, che collezionava nel suo cabinet de curiosité, un luogo magico e appartato. Lì la fascinazione si viveva nel segreto, o in una condivisione con persone elette, che si accoglieva nel proprio tempio delle bizzarrie come in un cerimoniale, un rituale. Le wunderkammer nascevano con un intento voyeuristico meno esplicito. Certo, c’erano oggetti che venivano prelevati da culture altre e inseriti come reliquie strane ed esotiche, per generare un tipo di apprezzamento morboso. Ma l’associazione fra l’oggetto e la persona non era così diretta, ma soprattutto non c’era una dichiarata complicità fra il godimento del collezionista e il proprietario di quelle immagini. Oggi invece le immagini sono i volti di persone che si dilatano e si espandono sullo schermo a nostro piacimento, per risalire dalle lacrime gocciolanti agli occhi rossi e ingrossati. Una collezione viva, in cui l’oggetto e il soggetto si nutrono di una mutua complicità. Ma molti influencer hanno la scusa della divulgazione, dei contenuti atti a sensibilizzare un problema di salute, così come molti amatori del passato avevano la scusa del fascino esercitato da oggetti magici o religiosi rubati da culture altre da quelle europea, per esporli nei musei di antropologia e farli conoscere al “Mondo” inteso come occidente, una logica di appropriazione che rivela un comune nucleo problematico.
Sorridi o piangi, ma fallo in fretta!
L’estetica di TikTok nega l’idea stessa di comunicazione: si comunica solo alla pancia. Il montaggio veloce, gli zoom su espressioni esagerate, i movimenti sincopati che richiamano certi video ipnotici per bambini che fanno regredire solo a vederli. Qualsiasi cosa dici non viene dopo, viene direttamente espulsa. Il fatto che tutti stanno adottando questo linguaggio, che sia il profilo social di un politico o di un programma culturale, non può che che portare a qualcosa di disastroso, qualcosa di più di un disturbo dell’attenzione, come ci ripetono gli influencer che “sensibilizzano” sull’ADHD, ma qualcosa che intacca la nostra capacità di articolare un pensiero, che ha bisogno per maturare, invece, di essere scandito e articolato nel tempo, uscendo dalla logica della sincopata dinamicità dei video, e dello sbrodolamento smodato delle live.
Il disturbo è diventato spettacolo da fruire, da ingoiare, in un sol boccone, in un solo sorso. Questo spettacolo è reso iper-mediatico da piccoli lavori di montaggio che riescono, nel dramma che esibiscono, a renderlo parte di un grande intrattenimento. Ammiccamenti, accenni di balletti, canzoncine mezze abbozzate. Chi lo fruisce non si immedesima né si trova alla giusta distanza per poter empatizzare: è buttato dentro quasi di forza. L’unica forma di “piacere” che si ricava dalla fruizione di queste testimonianze, reificate in immagini che riassumono un climax di malessere più o meno reale, è un piacere che ricerca la giusta distanza attraverso una de-umanizzazione del soggetto, del malato di turno che si appiattisce nella sua identità social di malato. Diventa solo quello, per tutti. Alla fine, lo si guarda come un animale in gabbia, come un oggetto esotico che pure dice qualcosa di noi, suo malgrado. E quindi, paradossalmente, diventiamo meno umani nel tentativo di difenderci dallo straniamento di questa eccessiva esposizione, così come i collezionisti dopo l’accumulo di troppi oggetti – preziosi coralli, strane matrioske, vasi cinesi, maschere totemiche, feticci animali, bezoar africani, fossili, ambre – rischiano di cedere all’avidità, e quindi all’appiattimento del proprio patrimonio, perdendosi come in un mare di confuse cianfrusaglie.
Dietro la passione per le Wunderkammer si ravvisa la traccia del pensiero alchemico, della trasformazione della materia. L’oro, il metallo più prezioso, è il traguardo utopico di questo processo. Tornando ai nostri giorni, ora su TikTok si monetizza un dramma o un malessere facendolo diventare oro, moneta e soldo che parodizzano la purezza dell’oro alchemico. Serena Mazzini, nel suo recente e illuminante saggio, Il lato oscuro dei social network, Come la rete ci controlla e ci manipola, fra le numerose tematiche, tratta proprio quella della sovraesposizione mediatica di casi di speculazione, spesso su minori, dove questo fenomeno è finalmente rivelato nella sua capillare perversità. Nell’addentrarsi in questi labirinto di immagini piangenti e danzanti, in quanto la “cornice” di questo acting out resta quella di una piattaforma fatta per i balletti, conia la definizione di “capitalismo della pietà”. Paradossalmente, emerge uno scenario che ci riporta nell’epoca dei collezionisti del Seicento, dove si pensava che i bambini non avessero un’anima. La mortalità infantile era alta e le famiglie numerose, la madre nelle prime fasi di vita veniva per lo più sostituita con la figura della levatrice, che assisteva la partoriente ben oltre la maternità. La retorica della buona famiglia borghese non è che un’invenzione dell’Ottocento. Sugli schermi di oggi i bambini non sono che strumenti retorici che stimolano like e commenti di commozione, mentre la loro infanzia viene venduta a caro prezzo, sostituendo la fase dello specchio di Lacan con la fase dello schermo. Oltre il corpo, virtualizzato, e la malattia, spettacolarizzata, non resta più uno spazio lontano dagli sguardi indiscreti in cui l’anima possa rifugiarsi. La stand up comedian, invece, Martina Catuzzi, nel suo brillante monologo sul tema delle disgrazie sul web restituisce il lato grottesco dietro a queste dinamiche, sempre più comune, mettendo in scena ciò che resta spesso invisibilizzato.