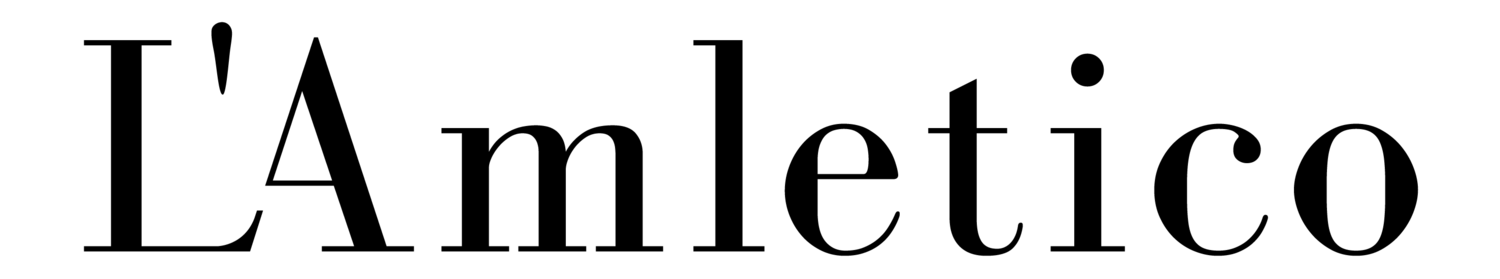Si può davvero rapire l’Europa?
Tiziano, Il ratto d’Europa, Isabella Stewart-Gardner Museum, Boston, 1560-1562.
Ouverture
Tutti conosciamo il mito del ratto di Europa, la cavalcata della bella ninfa sopra Zeus, trasformato in toro bianco per rapirla, per renderla oggetto del suo eccesso di amore. Violenza, abuso, orrore, in ogni caso questa sublime corsa a perdifiato ha dato forma al nostro continente, disegnando l’immagine di una cultura sempre in movimento, che ha fatto della migrazione e dello scambio la sua ricchezza. Questo abbraccio iniziatico fra divino e umano, umano e animale, maschile e femminile è stato di ispirazione a numerosi artisti, che hanno mostrato in questa accoppiata un tripudio di vita e bellezza, ma non di meno di paradossale grazia. Cosa rende così suggestiva la scena? Possibile sia solo la sublimazione di uno stupro? No, deve esserci dell’altro… e la traccia di questo enigma si disperde nei territori erbosi e desertici marchiati dagli zoccoli della bestia, nelle tracce aeree delle urla della fanciulla, di cui ancora si avvertono gli echi lontani. In questi tempi tumultuosi, dove si parla di un riarmo che rischia di tradire i valori su cui si è costruita la nostra cultura, ri-ascoltiamo la favola ovidiana, dove la metamorfosi non offre una via di fuga dal reale, ma una possibilità di trasformarlo, e di viverlo meglio. O meglio: rinarriamo questa stessa storia, così come la cultura europea ha sempre fatto non tanto per aggiornare i suoi miti, ma per assaporare ed esplorare ogni sfumatura, fino a far albeggiare l’avvenire.
Atto I: Chi è il nemico? Lui? Io? La vertigine rende più chiari i sussulti del mio ardore
Nessuna minaccia in fronte, lo sguardo non fa paura,
il muso è in pace. Lo contempla la figlia di Agenore,
come è bello, e non minaccia battaglie;
ma, per quanto mite, ha paura a toccarlo dapprima,
poi gli si accosta e porge fiori davanti al candido
muso.
Ovidio, Metamorfosi, II, pp. 846-875.
Il toro che ha rapito Europa era bianco, come un giglio, un attribuito virginale, associato tanto alla Madonna quanto all’unicorno, bestia amica delle fanciulle illibate. Premura ipocrita da parte del padre degli dei? O toccante omaggio alla natura pura della ninfa? Ciò che poteva risolversi in un semplice stupro diviene un viaggio immaginifico. L’animale si mostra con delicatezza e poi si rivela con brutalità: questa successione di movimenti spiazza, così come sono spiazzanti le sue intenzioni. Un Dio che si fa animale richiama subito alla mente storie tribali e arcaiche, sebbene Zeus succeda al più primitivo Crono, legato alla terra in modo simbiotico, e a un immaginario decisamente più brutale del festino mondano dell’Olimpo. Eppure, Zeus per giungere a ottenere la fanciulla che brama, si fa animale, risale indietro nella sua genealogia per trovare parentele con un animale che è simbolo della forza più virile e brutale: il toro. Numerose divinità come Marduk e Baal sono state associate al suo attributo più evidente, le corna, per mostre il suo lato temibile e ammirevole.
La versione pompeiana del ratto di Europa, oggi conservata presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, mostra un toro placido, adorabile come un grande cagnolone. La ninfa è proprio una donna in villeggiatura che si gode il suo sogno di gloria pagana nella più serena disposizione d’animo. Tiziano, invece, nella rappresentazione più celebre del mito, mostra un momento di piacere debordante. La materia pittorica risente dell’onda di un godimento che arriva fino allo spettatore. Impossibile non emozionarsi davanti a questi colori sognanti, che richiamano la magia di un sogno. La terra è oramai lontana all’orizzonte: certe persone gridano forse il suo nome, ma i loro volti non sono più che tracce di pigmento colorato. La bestia tanto temibile qui sembra ancora più docile che nella descrizione ovidiana: quasi una pecorella di zucchero, adornata da una corona di foglie che riluce di oro nei bagliori del crepuscolo. Si direbbe dell’alloro, come a dire: questo amplesso è già poesia. Europa è sdraiata come una Venere sul lettino, l’animale col suo vello sembra quasi una sofisticata chaise long, e no, non sta per scivolare nonostante l’apparenza, il suo equilibrio è perfetto. Centrata nel suo ruolo di mortale che diviene una dea immortale del regno della pittura. Rembrandt anche ha capito questo, mostrando un’immagine solo apparentemente calma, che in realtà rivela uno stato di abbandono dove la staticità ha qualcosa di metafisico: il distacco dalla terra è inevitabile, eppure non si va in cielo, non si abbandona il mondo, no, si entra in acqua per esplorarlo in lungo e in largo, per conoscerlo carnalmente…
Questa storia continua a inebriare per la sua poesia nonostante i secoli, ma ha ispirato molto più gli artisti degli scrittori. Forse il motivo è che questo motivo del rapimento è quasi una cornice, una sorta di meta-mito fondativo di una cultura che ha incontrato l’altro a più riprese, sia in modo pacifico che bellicoso, ma non l’ha mai rifiutato. Il sapere, la bellezza, la giovinezza: storia di furti, di incursioni, di eventi che si danno di passaggio come il rapimento estatico e orgasmico. L’Europa è il luogo, lo spazio geografico mutevole e sfaccettato, la città del pensiero o della sua nemesi, che si scontrano e si incontrano in modo scenografico. È un’entità porosa in cui tutto è costantemente messo in discussione. La cultura europea è questo, non bandierine appese che richiamano a quelle delle feste di compleanno dei bambini. Non si ruba ciò che è senza proprietà, ciò la cui natura è multipla, eppure inscritta nel DNA di una cultura ricca di risvolti sempre inediti, da approfondire, da ri-contestualizzare. Non si tratta di cedere alla facile retorica, come quella di Roberto Vecchioni alla piazza per l’Europa di Roma. Niente applausi, niente sottintesi stucchevoli e vanitosi. Incredibile come le sue parole suonino vicine ai ritornelli di una certa destra il cui potere oggi si espande a macchia d’olio, e che ha eletto un nuovo nemico.
Europa sul Toro salutata dalle sue compagne prima di giungere a Creta, dalla Casa di Giasone (Pompei). Attualmente presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Affresco, 20-25 d. C. ca.
Le ideologie che hanno costruito la cosiddetta “woke culture” negli USA, contro cui partiti più o meno razzisti, fascisti, omofobi e xenofobi, si indignano, hanno ripreso molto dell’ambiguità di queste storie e di queste immagini europee, banalizzandole. Ma come è più gustosa la leggenda quando non si riduce a morale spicciola? Da divulgare in un carosello social. La suggestione che propongo è che Zeus non si è solo fatto animale per unirsi a Europa, ma ha fuso anche la mascolinità con la femminilità, una metamorfosi all’insegna della violenza e dell’animalità. Un dio-padre queer? Non direi… a meno che non si opponga una mise en abyme a questo termine. Riprendiamo i quadri di Tiziano e Rembrandt, osserviamoli ancora, questa mistura dove si gode indifferentemente della scena attraverso il potere della pittura e della cultura europea. Questa non è un’arte di Narciso, dove l’identico, il medesimo, l’ovvio si bacia in una storia già scritta, dove i valori di partenza, i significati, sono confermati prima ancora che l’avventura inizi. La fucina dell’Europa si è sempre occupata di questioni che mettevano in discussione l’identità dei corpi, dei pensieri, delle vite. L’arte, sostiene Georges Bataille, non nasce da Narciso, dal suo riflesso nello specchio d’acqua, ma dal Minotauro nel gioco del labirinto di Cnosso, nei suoi corridoi dove lo sguardo, il corpo e la centralità del soggetto si disperde. Il minotauro è già una nuova versione del Dio-toro, un toro-umano che ha un’identità altra: è straniero, non assimilabile al maschile, all’uomo. Siamo a metà fra natura e cultura… e se la chiave fosse qui? Forse è la sua natura criptica e bizantina, la matassa da cui estrasse il gomitolo, il filo rosso di Arianna. Lasciamoci catturare dalla bellezza della sua corsa, il labirinto, in fondo, non è una prigione.
Atto II: tu che mi amasti così violentemente, mostrami nel tuo volto di bestia la nostra libertà sublime
Marguerite Yourcenar ha fornito una splendida ri-definizione teatrale dell’alterità taurina, nella pièce Chi non ha il suo minotauro? Qui la creatura è un entità sfuggente e impenetrabile, eppure non di meno legata alla psiche dell’uomo in modo inestricabile. Nella sua forma bestialmente divina e virile, fino a sfociare nell’androginia più primordiale, ma al contempo più contemporanea. Se, infatti, l’androgino, così come lo concepiva Platone, si poneva, all’origine dell’umanità, come un essere perfetto, completo – da cui sarebbero nate le forme divise di uomo e donne –, qui l’intreccio femminile/maschile/animale offre una formulazione che tiene insieme la complessità della questione di genere. Le femme fatale dell’antica Grecia contemplavano tutte un aspetto mostruoso: Medea, Circe, Medusa… erano donne magiche, quindi legate al potere totemico di tigri, serpenti, draghi… questa associazione, stratificatasi nella memoria culturale, è arrivata fino a noi, nel romanzo ottocentesco, con le donne vampire (in senso letterale, come Carmilla, ma più spesso in senso metaforico), alla narrazione fantascientifica (basti pensare ad Alien, nella lettura della filosofa Rosi Braidotti, intesa come un demone materno che si scaglia contro il figlio ingrato della civiltà), ma gli esempi potrebbero essere infiniti. In ogni caso, il mostruoso si lega all’animale, in quanto sua immagine deformata dalla paura, e insieme questa moltitudine si oppone all’opera dell’uomo civilizzatore, che vuole imporre ordine al caos, ovvero sottomettere la natura alla sua cultura.
Rembrandt, Il ratto d’Europa, Getty Museum, Los Angeles, 1632.
Oggi, alla luce della teoria sulla differenza sessuale, sappiamo che questa complementarietà uomo/donna non può esistere, così come non può esistere il dualismo uomo/animale. Non c’è subordinazione o gerarchia che non sia falsata dall’antropocentrismo, da un falso senso di superiorità che svela insicurezze ataviche. Non ci sono due “esseri” che si completano, l’uomo che viene da Marte e la donna da Venere, perché questo non farebbe altro che riproporre il gioco dello specchio, un circolo vizioso dove l’Io non può che ri-guardare sé stesso, perdendo di vista l’altro. Scrive Manuela Fraire, in La porta delle Madri (2023), che la differenza sessuale non si basa sulla diversità biologica o culturale fra uomo e donna, ma su quel quid che li separa e unisce nella differenza. La differenza si da nel confronto, nel dialogo, anche (e soprattutto) dove questo è difficile: nei territori di frontiera. Per guardare in faccia l’altro, riconoscerlo ci vuole un coraggio che manca a Narciso, che può solo vederlo riflesso in uno specchio, dove questo può apparire, ovviamente sullo sfondo, immensamente più oscuro e minaccioso. La crudele Russia… la spietata Cina… gli ammirevoli, e falsi alleati, USA… allora la paura prende il sopravvento. Il bel narciso può diventare un bel soldatino, perché se è tanto bello sarà anche atletico, e per proteggere i suoi bei boccoli dorati indosserà un elmo, e, al posto dello specchio, impugnerà una sua versione ancora più micidiale: un fucile, un’arma per far sparire l’altro.
Atto III: Non cercare altra guerra che non sia in te, tu che mi hai rinsegnato la pace
Contro questo ideale virile e guerrafondaio, associato all’immagine idealizzata della figura del guerriero, si è scagliata, qualche giorno fa, l’ex ambasciatrice Elena Basile. Un’Europa che si riarma vuole dare questo messaggio al mondo: siamo forti e virili anche noi, perché possiamo usare le armi, possiamo costruire nuovi giocattoloni iper-tecnologici per una fanta-terza guerra mondiale con risvolti grottescamente apocalittici. Ma quest’immagine tutta maschile della forza, non è che uno spauracchio della forza, che invece ha tante forme, e si nutre di tante identità. Maschile, femminile, animale: dall’intreccio e dalla mescolanza nascono le specie forti, le più feroci, ma anche le più adattabili, che sanno resistere agli ecosistemi più ostili. Il determinismo biologico, nato da una certa, e riduttiva, lettura dell’eredità darwiniana, dimentica l’aspetto culturale, quindi la quota di libertà riservata all’animale umano. La cultura è forza nel momento in cui si crede in essa. Grazie a essa si può essere furbi, scaltri, anche spietati per un fine alto e nobile ma non idealizzato. Non è la “poesia per la pace” che si legge in televisione cercando facili applausi, un consenso che fa contenta solo una borghesia polverosa e salottiera. L’Europa può prosperare nel commercio, può investire per la realizzazione di una realtà intellettuale più fertile e dinamica, che include l’altro nella sua differenza, e mette al centro la qualità della vita dei suoi cittadini. Il suo dominio risiederebbe, allora, nella pienezza che offrirebbe all’esistenza di tutti. Un rapporto proficuo con il mondo basato sull’interesse reale, e non su falsi ideali che schermano la vista, è la chiave per uscire da questa trappola narcisistica, dove l’uomo può solo riconoscersi virile pensando all’immagine della sua forza in una veste stereotipata. Ma questa è una fragile facciata, che subito si infrange davanti alla violenza di un ruggito che viene dalla profondità di noi stessi. La forza è il toro, il minotauro, la bestia che le prova tutte per sopravvivere, perché ogni colpo è buono, e qualsiasi natura umana può rispecchiarsi in questa mitologia. Un riflesso non simmetrico, ma aperto, sfalsato: è la Ninfa Europa che volteggia sopra quest’estasi di bellezza e orrore.
Finale
Se c’è una cosa che ci distingue dagli statunitensi, è che noi europei non abbiamo bisogno degli Avengers, dei pupazzi dei super eroi della Marvel negli store della Disney. Il nostro patrimonio è più ricco e complesso, ma soprattutto profondo. Le tutine attillate, i mantelli di plastica, i capelli neri gellati all’indietro come la macchietta di un gentleman, i gadget pacchiani e le citazioni ai miti norreni e romani ridondanti: lasciamoli a loro. In noi c’è una memoria viva fatta di carne, ma prima di inorgoglircene troppo velocemente dobbiamo riattivare quei ricordi antichi, affinché ritornino a risuonare dentro di noi come una musica più inebriante di una marcia militare. Allora aggrappiamoci all’animale che siamo, lasciamo perdere i fucili che vorrebbero arrestare la sua corsa, andiamo verso il nostro mutuo profitto, dove la fame di vita per creare nuove opportunità ci espone al rischio di evolvere insieme. Solo allora il desiderio di acculturarsi diventa più di un’aspirazione sbiadita, riservata a una élite annoiata dagli stessi libri che fanno il suo ego. Questo desiderio deve farsi bruciante, deve incendiare le barriere e le inibizioni. Stabilire nuove relazioni, creare nuovi ponti, ibridare nuovi linguaggi.
La Ninfa Europa non ha mai desiderato così tanto sentire la sensazione del vento fra i suoi capelli, svolazzanti in queste continue raffiche di un passato tumultuoso, che ritorna come una folata improvvisa. Zeus nella sua forma animale attraversa imperterrito perfino le acque, nemmeno le onde del mare aperto lo spaventano. Per conservare il miracolo di questo equilibrio serve anche concentrazione: un obiettivo fisso, in cui direzionare lo sguardo. Nell’occhio del ciclone risiede il punto di fuga in cui rivoluzionare il mondo, così come nel Quattrocento gli artisti fiorentini aprivano prospettive prima di allora inimmaginabili, così oggi si può ricercare l’origine eccentrica di quell’estro geniale per ribaltare una situazione di scacco in una fonte di insperate possibilità, germinanti come trionfo di frutta, da una cornucopia proveniente direttamente dall’Ade.
Antonio Bellucci, Ratto di Europa, Ca' Rezzonico, Venezia, 1703-1706.